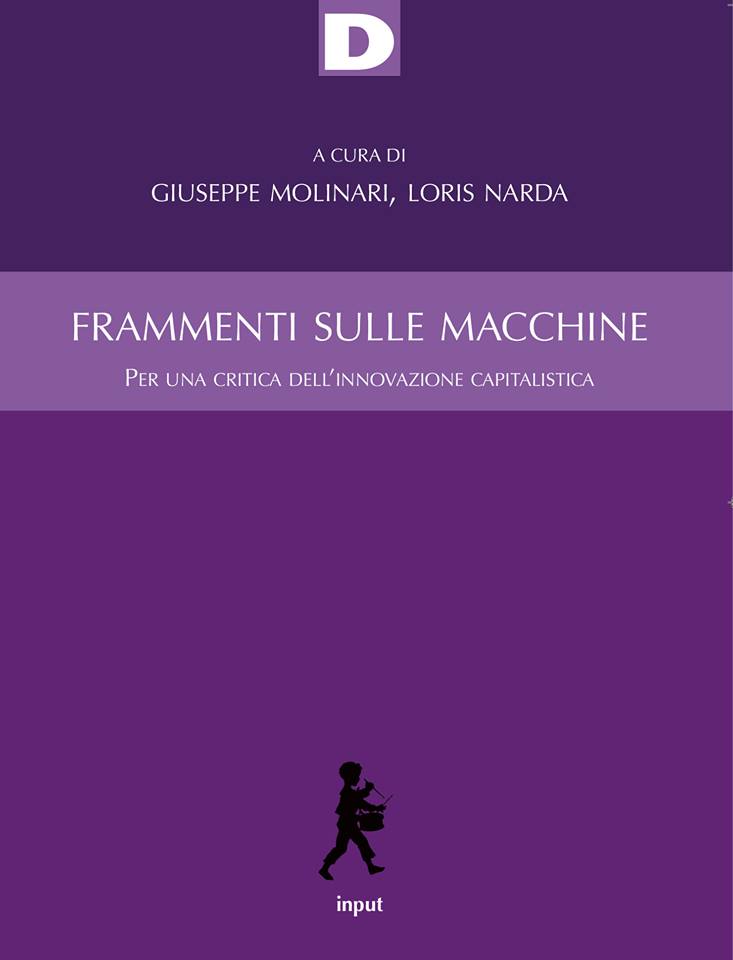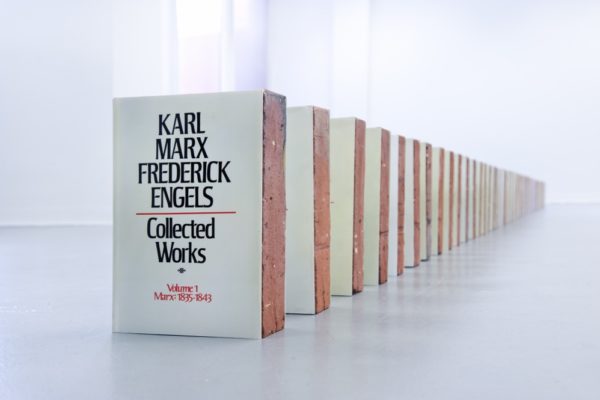di Paolo Costa
A che punto siamo?
Trascorso ormai più di un mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria che è piombata come un meteorite sulle nostre vite la tentazione di provare a fare un bilancio provvisorio del suo significato storico è quasi irresistibile.
Per prevenire l’obiezione dello scettico o del naturalista militante, do per scontato che un’epidemia di per sé non «significhi» nulla. Quando parlo di «significato» non mi riferisco cioè a una sorta di morale della favola inscritta a caratteri cubitali in ciò che sta accadendo attorno e dentro di noi, ma all’intersezione tra un fenomeno naturale, che segue ciecamente la sua traiettoria priva di finalità, e la trama di intenzioni dirette e derivate in cui consiste l’esistenza di una specie di animali intelligenti come la nostra. L’intersezione di questi vettori indipendenti dischiude un campo di significati che suggerisco di concepire come un ambiente intenzionale, cioè come uno spazio (non omogeneo) di azioni possibili.
In parole più semplici sto per chiedermi con che volto si presenti oggi il mondo a qualcuno che non possa fare a meno di agire in e su di esso. Non c’è bisogno di aggiungere che il bilancio che sto per fare è prematuro, un vero e proprio azzardo se misurato con i criteri del sapere distaccato, ma – come cercherò di chiarire mano a mano che il mio ragionamento prenderà forma – il mio obiettivo qui non è tanto la conoscenza fine a se stessa, quanto piuttosto la qualità dell’equilibrio riflessivo che guiderà le nostre scelte nelle settimane, mesi e, se vaccino e terapie tarderanno, anni a venire.
Il massimo danno con il minimo sforzo
Ebbene, dopo aver visto il nuovo coronavirus all’opera, mi è capitato spesso di pensare che se a una razza aliena superintelligente o, che ne so, ai maliziosi dei dell’Olimpo fosse venuto il ticchio di escogitare un’arma per procurare alle nostre società il massimo danno con il minimo sforzo, perfino loro avrebbero faticato a immaginare qualcosa di più efficace di quel replicante ottuso che abbiamo ribattezzato SARS-CoV-2. In effetti, tenuto conto di come funzionano le società moderne, è veramente difficile figurarsi una minaccia più subdola e abile nel colpire con precisione millimetrica i punti deboli della nostra forma di vita.
Provo a spiegare perché.
Il primo dato che viene spontaneo menzionare è come il virus sia riuscito nell’impresa di cogliere quasi tutti impreparati. Se si escludono quegli Stati (ad esempio la Corea del Sud) costretti a gestire nel recente passato focolai epidemici di sindromi respiratorie gravi come SARS e MERS, la progressiva adozione da parte dei principali paesi occidentali di provvedimenti eccezionali come la quarantena e il distanziamento fisico dei cittadini, più che come una scelta pianificata, è apparsa come la pura e semplice capitolazione di fronte a una sorta di implacabile effetto domino. Di fatto nessuno, nonostante il vantaggio temporale garantito dalla distanza geografica, è riuscito ad anticipare gli eventi. Chi più chi meno, tutti si sono arresi solo al fatto compiuto.
La causa psicologica di questa sottovalutazione sembrerebbe essere una caratteristica ben nota della psiche umana: l’inclinazione, cioè, a non cambiare abitudini consolidate finché la minaccia non diventa incombente o tangibile. Questa forma di negazionismo, come si è potuto constatare ripetutamente grazie alla asincronia tipica dei fenomeni diffusivi, ha riguardato tutti i paesi a prescindere dalle differenze culturali e si è manifestata senza eccezione nella tendenza quasi automatica a considerarsi un’eccezione. Quest’ultima ha toccato picchi di denial vitalistico in Italia con l’assalto alle piste da sci nel weekend precedente il lockdown deciso dal governo il 9 marzo 2020, ma si è riproposta secondo uno schema fisso a Madrid, Zurigo, Berlino, Amsterdam, Londra, New York o sulle spiagge della Florida e della California.
Viaggiare senza pilota
La riluttanza delle nostre comunità a fermarsi o anche solo a rallentare non ha ovviamente solo una spiegazione psicologica. Non serviva di certo una pandemia per prendere coscienza del fatto che a partire dalla Rivoluzione industriale la scommessa moderna ha significato in sostanza lasciare che prendesse forma un reticolo di interazioni e dipendenze economiche talmente intricato che nessuno è più in grado né di governare né, cosa ancora più inquietante, di monitorare. In effetti, oggi è praticamente impossibile figurarsi nel dettaglio quali effetti sulle nostre vite potrebbe avere l’eclissi o un forzato ridimensionamento della selva di sistemi d’azione che abbiamo lasciato proliferare nel corso degli ultimi tre secoli. Le metafore sociologiche classiche in questo ambito sono quelle della locomotiva lanciata a bomba verso un ignoto termine corsa o di un aereo senza pilota e non fanno certamente dormire sogni tranquilli.
Ora, quando il funzionamento di questo mastodontico dispositivo viene ostacolato da una minaccia esterna o interna ordinaria (ad esempio la politica estera aggressiva di una nazione confinante o gli attentati di un gruppo terroristico), lo Stato e i suoi cittadini hanno un’idea relativamente chiara di che cosa possa significare affrontare efficacemente l’emergenza. Quando invece, come nel caso dell’epidemia di CoViD-19, il funzionamento della macchina viene inceppato da un nemico invisibile, privo di qualsiasi intenzione calcolabile e di cui è difficile prevedere con precisione la pericolosità (in particolare la letalità a livello individuale), la semplice forza d’inerzia dello status quo può diventare un ostacolo formidabile.
Ne abbiamo avuto una prova eclatante nelle prime settimane dell’emergenza sanitaria osservando le titubanze e i dietrofront dei decision makers un po’ ovunque nel mondo. I dubbi erano più o meno sempre gli stessi: a che punto è inevitabile «fermarsi»? E bisogna fermarsi per non fare niente o per fare le stesse cose diversamente? E, visto che non è possibile fermare tutto, chi deve rinunciare a cosa? Ma, poi, chi può onestamente dire di possedere il know-how per poter stabilire con cognizione di causa qual è la parte di vita a cui è doveroso rinunciare oggi o non sarà possibile rinunciare domani?
Costi e benefici
Avendo a che fare con un virus la cui diffusione è apparsa fin dall’inizio allarmante più in senso statistico che personale, l’effetto di deterrenza del contagio non ha mai toccato vette tali da azzerare i dubbi di chi, ad esempio, tende a considerare il rischio – e il conseguente calcolo dei costi e dei benefici – come una componente ineludibile dell’esistenza umana. Non sono poche le persone con una forma mentis del genere nelle nostre società, e occupano spesso posti di vertice nella scala gerarchica di comunità politiche che, a dispetto degli ideali democratici che innervano le loro costituzioni, restano fortemente disuguali.
Sebbene ancora oggi l’argomento a sostegno del lockdown più difficile da confutare sia quello (prudenziale) avanzato da quanti, fin da tempi non sospetti, hanno messo in guardia contro i rischi di un collasso del Sistema Sanitario Nazionale sotto la pressione di un numero ingestibile di ricoveri nei reparti di terapia intensiva, nemmeno questa profezia apocalittica ha però impedito che l’opinione pubblica si polverizzasse rapidamente in piccole ma acrimoniose dispute di bandiera. La polarizzazione è stata favorita, tra l’altro, dalla franchezza urticante di ragionamenti utilitaristi come quelli che si sono letti per esempio in un editoriale dell’«Economist» («fino a quando potremo permetterci di dire che una vita umana non ha prezzo?») o, sul fronte opposto, dall’aplomb anticonformista di critici raffinati della forma di vita moderna come Giorgio Agamben, che, noncuranti delle conseguenze, si sono prematuramente scagliati contro la scelta a loro avviso avventata di rinunciare a fondamentali libertà personali per salvaguardare la salute pubblica.
In effetti, fin dalla prima ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio il pendolo del dibattito politico in Italia (e non solo) ha preso a oscillare da un estremo all’altro (ossia dal «non fatevi abbindolare: è poco più che un’influenza» al «no, ti sbagli, è il segno inequivocabile dell’inizio del collasso dell’antropocene») senza che gli umori delle persone si saldassero mai, nemmeno provvisoriamente, in una tonalità emotiva prevalente. A vivacizzare le piazze reali e virtuali del paese è stato piuttosto un caleidoscopio di stati d’animo in bilico tra fatalismo e ironia, ansia generalizzata ed euforia, speranza e ostilità, scetticismo e depressione, frustrazione e noncuranza. L’unico elemento comune in questa condizione di labilità diffusa è sembrato essere un nuovo diffuso senso della fragilità della condizione umana.
Fragili ma non inermi
A uno sguardo attento, però, anche questo apparente denominatore comune rivela una divaricazione interessante. Non è difficile rendersene conto se, anziché farsi sopraffare dal pathos della vulnerabilità, uno si sforza di capire meglio che cosa hanno in mente le persone quando evocano questa fantomatica «fragilità». È indubbio che la fonte principale del disorientamento generale suscitato dalla scoperta che il nuovo coronavirus si era ormai diffuso in molte regioni italiane sia stato il senso di impotenza di fronte a una minaccia invisibile e indeterminata. Ma esattamente quale aspetto della vita quotidiana è stato vissuto come minacciato in maniera inedita dal virus?
Da un lato, per alcuni è stato uno shock constatare fino a che punto la qualità della vita morale delle persone dipenda da condizioni esterne che sfuggono al controllo di chi agisce. In effetti, l’incertezza generata dal rischio permanente di contagiare ed essere contagiati – a pensarci bene, la figura più emblematica dell’epidemia di CoViD-19 è proprio il paziente asintomatico, l’«untore» inconsapevole – può essere a buon diritto descritta come una condizione limite. Una verità che si tocca con mano durante un’epidemia è per l’appunto il fatto che il significato morale, per esempio, di un banale atto di gentilezza, come un abbraccio o una stretta di mano, può essere a tal punto influenzato dalle circostanze che, a prescindere dalle intenzioni di chi lo compie, da gesto di affetto o rispetto può addirittura tramutarsi nella causa di un danno fisico irreparabile.
Questa improvvisa fragilizzazione delle intuizioni morali più basilari, che ha finito per coinvolgere l’idea stessa di «civiltà», è incontestabile ed è una delle possibili cause del trauma collettivo che stiamo vivendo. Tutto è diventato incerto nelle nostre vite, persino la distinzione tra bene e male. Non è vero, però, che la percezione vivida della fragilità del bene ci renda necessariamente inermi. Gli esseri umani dispongono infatti di risorse per adattarsi anche a situazioni eccezionali e modulare i propri gesti senza tradire le proprie tavole dei valori. Lo dimostra, se ce ne fosse bisogno, la rapida e sofisticata inversione del valore morale della distanza nelle relazioni di cura a cui abbiamo assistito immediatamente dopo la proclamazione dello stato di emergenza.
Tali risorse supplementari non sono però il frutto, se non in rari casi, dell’iniziativa di individui isolati. Dipendono piuttosto da un repertorio di gesti, significati, simboli a cui gli interessati possono sì attingere creativamente, ma che sono subordinati alla vitalità dei legami sociali entro cui fioriscono le esistenze individuali. È insieme e grazie agli altri, infatti, che possiamo rispondere efficacemente anche a sfide storiche senza precedenti che ci costringono a rimodellare forme inveterate di vita comune trasformando, nei casi migliori, un’esperienza di privazione in un’occasione di empowerment collettivo. D’altro canto, se le epidemie di peste ci hanno lasciato in eredità gli ospedali moderni, non è insensato sperare che grazie a un virus più subdolo che potente possa nascere una concezione più realistica della dipendenza strutturale delle azioni e pensieri individuali dalle azioni e pensieri dei nostri simili.
La nuda vita
Per potersi sentire parte di una grande impresa cooperativa, è indispensabile, però, che il prossimo non venga vissuto come un potenziale nemico, cioè come il cavallo di Troia di cui un agente ostile potrebbe servirsi per realizzare i propri scopi malevoli. Questa mentalità da stato d’assedio, l’istintivo «si salvi chi può», è inutile negarlo, è un altro dei possibili effetti della rottura traumatica della continuità dell’esistenza provocata dall’attuale emergenza sanitaria. Una traccia di questa attitudine guardinga la si può riconoscere nella retorica bellicista che da un certo punto in avanti ha prevalso nel resoconto giornalistico dei momenti più drammatici della diffusione del contagio in Lombardia.
Alla base di questo sentimento di angoscia generalizzata c’è un senso di vulnerabilità diverso dall’esperienza della fragilità del bene descritta sopra. In questo caso l’epidemia è vissuta infatti principalmente, se non esclusivamente, come una minaccia contro il proprio corpo, e per di più come una minaccia costante, infida, che impone una vigilanza incondizionata. Date queste premesse, non stupisce che la solidarietà passi in secondo piano e venga soppiantata da un’ostilità diffusa, alla ricerca continua di una valvola di sfogo.
Un’altra conseguenza prevedibile di uno stato psicologico di allerta permanente è la pretesa che lo Stato, la scienza, il diritto, l’intera comunità nazionale assicurino lo stesso livello di rigore e disciplina quotidiana che gli individui osservano autonomamente per difendersi dal contagio e rigenerare volontaristicamente il senso perduto di dimestichezza col mondo stravolto da CoViD-19. La tutela che il proprio sistema immunitario non può più garantire a causa del nuovo virus la si esige cioè ora da agenzie esterne il cui scopo ultimo, però, non può essere la protezione assoluta dalla contingenza per ogni singolo individuo.
Ciò non toglie che pretendere da una persona che si sente fisicamente minacciata da chiunque incroci il suo cammino di prestare orecchio alle ragioni degli altri sia piuttosto velleitario. Al massimo la si può convincere ad aderire a un principio o a una regola generale, diciamo a uno stato d’eccezione senza eccezioni. Ha poco senso, invece, chiederle di mobilitare una risorsa, già scarsa in condizioni normali, come la fiducia incondizionata verso gli altri. È esattamente questo l’effetto socialmente più deleterio di un virus che, pur non essendo letale come la peste o il vaiolo, distribuisce i suoi doni avvelenati con un significativo grado di casualità.
Epidemie e infodemie
In questo modo, l’idea a prima vista fantasiosa secondo cui saremmo tutti impegnati in una guerra non convenzionale contro un virus alieno può trasformarsi velocemente in realtà grazie alla forza delle profezie che si autoavverano. Traendo slancio anche dalla condizione di competizione universale in cui ci siamo abituati a vivere da alcuni decenni, l’ipervigilanza è destinata infatti a trasformarsi gradualmente in una vis polemica che non fa sconti a nessuno: runner, bambini iperattivi, anziani un po’ suonati, mendicanti.
Un flusso così imponente di aggressività latente è per altro molto difficile da arginare in una società già normalmente sovraeccitata, dove viene giornalmente prodotta, consumata e smaltita una quantità sterminata di informazione usa e getta. Da che mondo è mondo le pandemie sono state non accidentalmente accompagnate da ondate di «infodemia», in cui sciami di ansia, speranze ingiustificate, rabbia o invidia sociale vengono periodicamente generati tramite esche abilmente preparate da incendiari di professione. La novità ora è che il confronto astioso tra le persone è a tal punto amplificato da un tratto tipico delle società pluralistiche, la frattura degli orizzonti etici, che diventa quasi impossibile sfatare il presagio, per evocare una celebre poesia di W.B. Yeats, che i legami siano sul punto di dissociarsi e il centro della nostra civiltà non possa reggere alla forza delle spinte centrifughe generate dal contagio.
A questo punto i timori per il futuro del tessuto sociale smettono di apparire come meri esercizi di stile di quanti vorrebbero, per esempio, che la metafora della guerra contro il virus venisse sostituita da quella più pacifista dell’incendio. La fondatezza di tali preoccupazioni fa piuttosto emergere la vera posta in gioco di questa come di qualsiasi altra epidemia di cui si abbia memoria storica, e cioè la qualità delle relazioni umani e, con esse, di beni fragili come l’autogoverno, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, il senso civico, ecc.
La nuda vita e i nostri impegni morali
È rispetto a questo pericolo che dovrebbe attivarsi la vigilanza delle persone di buona volontà oggi, sebbene il compito di sorveglianza, per le ragioni esposte sopra, sia tutt’altro che agevole. L’azione combinata di impreparazione psicologica, rigidità sistemiche, incertezza strutturale, senso di fragilità sociale e personale, sfiducia generalizzata è destinata infatti a mettere a dura prova il patto sociale inscritto in una forma di vita plasmata dalle leggi del mercato e, soprattutto, dalle conseguenti disuguaglianze economiche. È sotto la pressione di questo complesso di cause che il carattere precario dell’alleanza tra economia e vita che ha caratterizzato il capitalismo fin dalle sue origini sta tornando prepotentemente a galla e, con esso, il dubbio troppo spesso sottaciuto: lavoriamo, consumiamo, accudiamo per vivere o viviamo per lavorare, consumare, accudire?
Normalmente questa domanda ce la facciamo restando comunque entro i confini di quello che i greci chiamavano il bios, la vita coi suoi abiti, «buoni» o «cattivi» che siano, e senza scomodare zoé, la nuda vita, ossia il requisito minimo del mantenersi in uno stato di salute accettabile. La forza d’attrazione del capitalismo, notoriamente, risiede proprio nel fatto che, sebbene di tanto in tanto capiti di fermarsi a chiedersi se quella che stiamo vivendo sia o no, più in senso comparato che assoluto, una vita decorosa, appagante, spericolata, dilapidata, all’altezza delle nostre aspettative o potenzialità, ecc., in genere i più si accontentano di soppesare il grado di comfort che viene loro assicurato dallo stile di vita in uso mantenendo per quanto possibile sullo sfondo sia la questione della «buona» vita sia la questione della «nuda» vita. Insomma, ci si ferma volentieri un passo prima dell’abisso, disinteressandosi in genere della precarietà di tale posizione.
Se c’è una cosa che non possiamo più permetterci di fare oggi, invece, è proprio evitare di chiederci quale dovrebbe essere, a conti fatti, il giusto equilibrio tra la nuda vita e tutto ciò che rende una vita degna di essere vissuta. Anche per questo ha senso descrivere la condizione che stiamo sperimentando in questi giorni come una situazione limite che reclama una serietà speciale. Non solo è urgente domandarsi quali sacrifici siamo disposti a fare nel nome della salute, ma è doveroso mettere in fila uno per uno tutti i nostri dubbi chiedendosi pazientemente: sacrifici nel nome della salute pubblica o personale? E quali margini di rischio sono tollerabili? E quale rischio: un rischio calcolato o generico? E come la mettiamo con la sorte? E con le eccezioni? E le disuguaglianze? E le ingiustizie? E così via.
Non a caso molti in questi giorni di straordinaria fibrillazione intellettuale hanno ricordato che le pandemie operano come una lente che ingigantisce i pregi e i difetti di una società e della sua forma di vita. I promessi sposi, in fondo, consentirono a Manzoni di tenere un’importante lezione storico-politica ai suoi lettori senza annoiarli con discorsi troppo astratti. E i capitoli dedicati alla peste erano senza dubbio il fulcro di quella lezione senza tempo. Non meno significativamente, parecchie persone nelle scorse settimane hanno sentito il bisogno di prendere o riprendere in mano un romanzo allegorico a lungo dimenticato come La peste di Camus, immergendosi nella tensione morale quasi insostenibile che avvolge la storia del dottor Rieux e prendendo mentalmente nota della differenza tra questo stato d’animo tonificante e l’effetto debilitante di quella condizione di ansia generalizzata che ha spinto, al contrario, la maggioranza di noi a misurare soltanto la propria spaventosa inadeguatezza.
Quale che sia il nostro umore dopo settimane di distanziamento fisico dai nostri cari, dai nostri luoghi dell’anima e dai nostri concittadini, resta comunque il fatto che non è nel nostro interesse distogliere lo sguardo troppo a lungo da quello che sta succedendo intorno a noi. Riallacciandosi all’immagine dell’ambiente intenzionale da cui ho preso le mosse, è forse più utile immaginare il mondo durante la pandemia come una regione devastata da un gigantesco incendio anziché come un paesaggio osservato col binocolo o una forma di vita analizzata al microscopio. Quello che ci si presenta davanti agli occhi è un panorama diversificato. Ci sono luoghi più fortunati che sono scampati alle fiamme, ma sono pochi e fungono più che altro da monito contro le facili illusioni. Accanto a essi appaiono chilometri e chilometri di campi devastati dall’incendio che ci sbattono in faccia il nostro way of life nella sua essenza – lo scheletro di uno stile di vita perso per sempre, con i suoi pregi e i suoi difetti, le sue potenzialità e i suoi limiti. Qua e là poi fanno capolino fazzoletti di terra già bonificati e pronti per ospitare nuovi modi di stare al mondo, diversi da quelli a cui eravamo assuefatti. Esiste un modo ragionevole di concepire questo ambiente trasfigurato come un possibile spazio di azione? È questa la domanda sgradevole che non dovremmo smettere di farci d’ora in avanti.
La fatica dei processi
È venuto il momento di azzardare il bilancio annunciato nelle prime pagine di questo articolo. Qual è, a conti fatti, la lezione generale che possiamo trarre dal breve periodo trascorso dall’inizio della nuova era post-CoVid-19?
La prima lezione è in realtà una meta-lezione. Non dobbiamo dimenticare, cioè, che siamo appena all’inizio di un lungo, faticoso e incerto processo di accomodamento e, auspicabilmente, di apprendimento. Se in genere le persone faticano a immaginare e affrontare le contingenze della vita in termini di processo anziché come eventi puntiformi, in questo caso il compito è ulteriormente complicato dal fatto che, per la natura stessa delle pandemie, dobbiamo progettare e realizzare una fuoriuscita dall’emergenza che non sia né un ritorno puro e semplice allo status quo ante né uno slancio vitalistico nell’ignoto.
Per quale motivo è faticoso assecondare la natura processuale dei grandi cambiamenti individuali e collettivi? Non è solo una questione di pazienza. Il punto è che i processi richiedono una specifica forma di attenzione e disposizione verso le cose che accadono. Volendo, si potrebbe descrivere questa attitudine anche come una forma di saggezza pratica che capitalizza una verità basilare dell’esistenza, ossia che la vita è un processo opaco nei suoi fini e assecondare il carattere processuale delle azioni è spesso l’unico modo per non farsi travolgere dagli eventi.
Se ci si pensa bene, una caratteristica distintiva dei processi è che hanno la struttura di una sinfonia: non possono cioè essere scomposti negli elementi che li costituiscono, pena la dissoluzione del loro senso immanente. E per godere pienamente di una sinfonia, in effetti, è necessario raggiungere uno stato d’animo capace di resistere alla tentazione continua di assolutizzare un momento dello sviluppo dei temi musicali (quello più drammatico, quello più elettrizzante, quello più malinconico). Lo stesso, fatte le debite proporzioni, vale per i processi di accomodamento e apprendimento.
Non tutti i processi, però, sono processi di apprendimento. Il primo obiettivo, allora, è proprio distinguere il carattere sinfonico ed esplorativo di tali processi dagli automatismi dei processi impersonali e sistemici. Già oggi possiamo infatti notare un’inerzia del cambiamento provocato dall’epidemia di CoViD-19 che non andrà in alcun modo assecondato. Sto pensando a fenomeni già ben visibili oggi come l’accelerazione di processi sociali che erano già in corso e che oggi beneficiano della forza inerziale dell’emergenza: l’isolamento forzato degli individui, la loro passivizzazione, l’astrazione ed escarnazione delle relazioni umane, l’esasperazione delle disuguaglianze, l’appiattimento dei conflitti sul solo conflitto generazionale, ecc. Questo tipo di innovazioni compulsive che obbediscono a logiche sistemiche o schiettamente ideologiche – ho in mente qui la «logica» di una sola idea di cui parlava Hannah Arendt alla fine delle Origini del totalitarismo – non sono utili, anzi ostacolano il compito difficile, incerto e creativo che abbiamo davanti.
Già ora non è difficile farsi un’idea chiara di che cosa possa significare lottare contro l’assolutizzazione indebita delle diverse fasi del processo di cambiamento innescato dalla pandemia. Vuol dire, per esempio, ricordare ogni piè sospinto che il distanziamento fisico imposto dall’urgenza di rallentare la curva esponenziale del contagio non si traduce immediatamente in distanziamento sociale. La posta in gioco nella polemica sulle metafore più adatte per cogliere la natura del momento storico che stiamo vivendo è precisamente la presa di coscienza del fatto che esistono situazioni speciali in cui distanziarsi dagli altri o rinunciare ad agire non è un modo per recidere le relazioni, ma per renderle possibili e, di conseguenza, poter beneficiare del loro salutare effetto di potenziamento, capacitazione, empowerment.
La metabolizzazione di questa verità basilare sulla condizione umana è tanto più importante oggi perché la distribuzione asimmetrica e accidentale del danno biologico personale in una società in cui sono già presenti forti disuguaglianze economiche e un latente conflitto generazionale è destinato a esercitare una pressione supplementare su legami sociali già messi a dura prova dalla cultura politica egemone negli ultimi decenni. E la prospettiva di dover gestire in un futuro prossimo anche la concorrenza sul mercato del lavoro tra persone provviste e sprovviste di un patentino di immunità al coronavirus, e insieme a essa le nuove forme di discriminazione che ne potrebbero derivare, non fa certo dormire sogni tranquilli. Lo stesso discorso vale per la distribuzione asimmetrica delle conseguenze economiche della pandemia a livello planetario che potrebbe spingere alcuni paesi a fraintendere il vero significato di tale disparità e indurle a intascare l’effimero vantaggio di posizione nell’illusione che la mancanza di solidarietà sia moralmente giustificata da un presunto merito collettivo o da una fantomatica superiorità culturale.
Fare pienamente i conti col carattere processuale dell’emergenza sanitaria significa inoltre non sottovalutare uno degli aspetti più dolorosi e preoccupanti della quarantena imposta dalle circostanze: la grave limitazione, cioè, della libertà di movimento da parte dell’autorità statale. Essere consapevoli della polisemia del concetto di libertà – del fatto, cioè, che non esiste solo la libertà individuale del non essere ostacolati dagli altri nel perseguimento dei propri fini, ma che ciascuno di noi beneficia anche della libertà delle istituzioni che garantiscono tale libertà a tutti e delle «migliori» libertà che gli altri ci fanno scoprire e senza i quali non potrebbero essere godute integralmente – aiuta solo in parte a sopportare il peso della privazione di questo bene fondamentale. Uno dei vantaggi del vivere tale privazione come uno stadio provvisorio in un tortuoso processo di accomodamento e apprendimento sta non soltanto nel fatto che così possiamo prepararci psicologicamente a rivendicare tale libertà non appena sarà ragionevolmente possibile farlo, ma anche nel metterci in guardia rispetto a ulteriori restrizioni della libertà personale, in particolare del diritto alla privacy, che ci verranno molto probabilmente imposte domani nel nome della salvaguardia della salute pubblica.
Un altro vizio atavico che rischia di ridurre drasticamente la nostra capacità di affrontare i problemi con l’atteggiamento giusto è, infine, la tendenza tipica di società prestazionali come la nostra a scivolare senza soluzione di continuità di emergenza in emergenza. Presto, lo sappiamo, l’emergenza sanitaria sarà soppiantata da quella economica che se non sarà risolta in fretta diventerà un’emergenza politica che potrebbe rapidamente degenerare in un’emergenza di ordine pubblico a cui seguirebbe un’emergenza democratica che a sua volta causerebbe un’emergenza diplomatica, e così via. Mentre è superfluo ricordare che esistono individui e gruppi che hanno un preciso interesse a terrorizzare la popolazione martellando sull’imminente catastrofe e agevolare così l’adozione di politiche pubbliche che modifichino a proprio vantaggio la distribuzione del potere coercitivo (diretto e indiretto) dello Stato e del Mercato, non è invece superfluo ricordare che il primo e principale antidoto contro questa mentalità emergenziale è proprio la comprensione e accettazione della fatica dei processi. Resistere alla tentazione di comprimere gli orizzonti temporali abbandonandosi alle pulsioni più reattive è il modo migliore che abbiamo per non spianare la strada al disastro e aprirci una via di fuga. Lo sappiamo già tutti per esperienza personale. È fondamentale, perciò, che non ce lo dimentichiamo proprio ora che la sfida sta per diventare cruciale per il nostro futuro.
Morale della favola
Riassumendo, affinché un processo di apprendimento abbia successo, è essenziale fare tesoro di ciascuna di queste lezioni: resistere alla tentazione di assolutizzare le fasi del processo; sopportare l’opacità del presente senza cedere all’impulso a chiudere troppo precipitosamente i conti con il passato o a restringere indebitamente il nostro orizzonte di possibilità; innovare in maniera creativa e non meccanica. Alla fine, tirate le somme, il significato storico della calamità naturale che ci è toccato in sorte di vivere potrebbe essere riassunto così: (a) siamo creature fragili, ma non inermi; (b) non siamo inermi nemmeno di fronte alle esperienze più destabilizzanti perché la nostra capacità di intessere relazioni significative aumenta esponenzialmente le nostre risorse individuali; (c) tali risorse non sono unicamente attivistiche – non ci consentono cioè solo di controllare e manipolare gli eventi – ma manifestano al meglio la loro efficacia anche in gesti di rinuncia o nella capacità di rallentare o invertire la direzione di marcia; (d) il valore dei nostri sforzi si misura sul lungo periodo: la resistenza è più importante del dinamismo.
Riferimenti bibliografici
A Grim Calculus: Covid-19 Presents Stark Choices between Life, Death and the Economy, «The Economist», 14, 5 aprile 2020, disponibile a: https://www.economist.com/leaders/2020/04/02/covid-19-presents-stark-choices-between-life-death-and-the-economy
Auf einmal sind wir nicht mehr die Gejagten (intervista con H. Rosa), «philosophie Magazin», 18 marzo 2020, disponibile a: https://philomag.de/auf-einmal-sind-wir-nicht-mehr-die-gejagten/
G. Agamben, Riflessioni sulla peste, 27 marzo 2020, disponibile a: https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-contagio.
H. Arendt, Ideologia e terrore, in Le origini del totalitarismo, trad. it., Edizioni Comunità, Milano 1967, pp. 630-656.
I. Beacock, Germany gets It, «The New Republic», 1 aprile 2020, disponibile a: https://newrepublic.com/article/157112/germany-gets-coronavirus.
A. Camus, La peste, trad. it., Bompiani, Milano 2017.
D. Cassandro, Siamo in guerra! Il coronavirus e le sue metafore, «Internazionale», 22 marzo 2020, disponibile a: https://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2020/03/22/coronavirus-metafore-guerra
A. Castelli, Il virus e la dignità della vita associata, «Le Parole e le Cose2», 9 aprile 2020, disponibile a: http://www.leparoleelecose.it/?p=38101.
I. Chotiner, How Pandemics Change History (intervista a F.M. Snowden), «New Yorker», 3 marzo 2020, disponibile a: https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-pandemics-change-history.
P. Costa, Possiamo salvare il pianeta prima di cena, ma non lo faremo, «Le Parole e le Cose2», 24 dicembre 2019, disponibile a: http://www.leparoleelecose.it/?p=37339.
P Costa, Siamo fragili ma non inermi: cambiare è possibile, «FBK Magazine», 16 marzo 2020, disponibile a: https://magazine.fbk.eu/it/news/siamo-fragili-ma-non-inermi-cambiare-e-possibile/
P. Costa, Emergenza coronavirus: non soldati, ma pompieri, «Settimananews», 28 marzo 2020, disponibile a: http://www.settimananews.it/societa/emergenza-coronavirus-non-soldati-ma-pompieri/
P. Giordano, Nel contagio, Einaudi, Torino 2020.
Y.N. Harari, Il mondo dopo il virus, «Internazionale», 6 aprile 2020, disponibile a: https://www.internazionale.it/notizie/yuval-noah-harari/2020/04/06/mondo-dopo-virus
M. Legros, Coronavirus e filosofia, Gauchet: “È un risveglio del politico”, «MicroMega: Il rasoio di Occam», 25 marzo 2020, disponibile a: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/03/25/coronavirus-e-filosofia-gauchet-%e2%80%9ce-un-risveglio-del-politico%e2%80%9d/.
A. Manzoni, I promessi sposi, Feltrinelli, Milano 2003.
S. Modeo, Tutto quello che la SARS ci aveva già predetto sul coronavirus (e che non abbiamo saputo ascoltare), «Corriere della Sera», 11 aprile 2020, https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_11/tutto-quello-che-sars-ci-aveva-gia-predetto-coronavirus-che-non-abbiamo-saputo-ascoltare-5def3030-7a73-11ea-880f-c93e42aa5d4e.shtml.
M. Nussbaum, La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, trad. it., il Mulino, Bologna 20042.
L. Penny, Questa non è l’apocalisse che ci aspettavamo, «Internazionale», 3 aprile 2020, disponibile a: https://www.internazionale.it/opinione/laurie-penny/2020/04/03/apocalisse-covid-mondo
R.A. Ventura, Coronavirus, sommes-nous paranoïaques?, «Le Grand Continent», 28 febbraio 2020, disponibile a: https://legrandcontinent.eu/fr/2020/02/28/coronavrius-paranoia/.
L'articolo Messi al tappeto da un coronavirus: non era Camus, è Asimov proviene da Le parole e le cose².